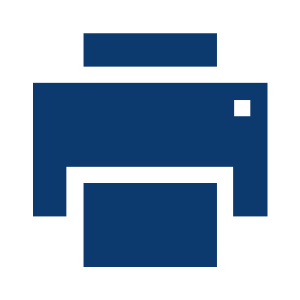La Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.4105/2023 ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può determinare in maniera induttiva la plusvalenza realizzata dal cedente, in caso di cessione d’azienda o di immobili, esclusivamente basandosi sul valore dichiarato, definito o accertato per l’imposta di registro, ipotecaria o catastale, accogliendo il ricorso del contribuente e rinviando al causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia per un nuovo giudizio, in diversa composizione.

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate (nei confronti di una Sas e dei suoi soci accomandanti ed accomandatari) sulla base dell’atto di liquidazione di una maggiore imposta di registro riguardante una cessione d’azienda, per la quale il cessionario aveva provveduto a versare integralmente l’imposta a seguito di definizione con adesione.
Tale valore definito da parte dell’acquirente ai fini delle imposte d’atto, è stato successivamente utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria anche per determinare la plusvalenza realizzata dalla società cedente, attribuendogli, pertanto, valenza probatoria anche nei suoi confronti ed ai fini dell’accertamento delle imposte dirette.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza in oggetto, ha però stabilito il principio di diritto secondo il quale l’art.5, c.3, del D.Lgs. n.147/2015, con efficacia retroattiva, in relazione alle imposte sui redditi, non consente all’Agenzia delle Entrate di utilizzare esclusivamente il valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte di registro, ipotecarie o catastali, per determinare induttivamente la plusvalenza realizzata con la cessione d’azienda o di un immobile. Sarà, pertanto, onere dell’Ufficio supportare l’accertamento di tale maggior valore rispetto a quello dichiarato, attraverso ulteriori indizi (gravi, precisi e concordanti), con la possibilità di fornire prova contraria da parte del contribuente.
Ciò, anche in considerazione del fatto, che, per costante giurisprudenza della stessa Corte, la base imponibile ai fini Irpef, non è rappresentata dal valore del bene, ma va calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta ed il costo d’acquisto, aumentato degli oneri ad esso inerenti.
L’ordinanza della Cassazione n.4248 depositata in data 10/02/2023 ha confermato quanto già statuito in precedenza, ovvero, che in caso di retrocessione dell’azienda affittata, al concedente vengono ritrasferiti solo la parte dei rapporti inerenti alle prestazioni non eseguite da entrambe le parti, mentre permane la responsabilità dell’affittuario per i debiti derivanti dal suo inadempimento rispetto all’obbligazione contratta durante l’affitto, salva la possibilità di applicare quanto previsto dall’art.2560 Cod.Civ. per la cessione d’azienda (responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti contratti dal cedente se risultano dai libri contabili obbligatori, che comunque rimane il titolare della posizione debitoria, al fine di tutelare i creditori dell’azienda).
Anche nel caso di affitto, come per la cessione d’azienda, l’affittuario subentra nei contratti stipulati dal concedente, ai sensi dell’art.2558 del Cod.Civ., ma secondo la dottrina prevalente non risponde per i debiti contratti in precedenza, che rimarrebbero in capo al solo concedente, mancando un espresso rinvio normativo all’art.2560 del Cod.Civ. (e pertanto, in caso di retrocessione dell’azienda affittata, anche per i debiti contratti dall’affittuario rimarrebbe solo la sua responsabilità).
Una precedente Sentenza della stessa Corte, ha ritenuto, invece, operante la responsabilità solidale del concedente in caso di retrocessione dell’azienda, anche per i debiti contratti dall’affittuario durante la vigenza del contratto. L’ordinanza attuale si è occupata di un contratto di affitto d’azienda, in cui l’affittuario subentrava in un contratto di somministrazione stipulato in precedenza dal concedente.
Tale contratto prevedeva una penale in caso di inadempimento della parte somministrata ed una volta verificatosi, il somministrante richiedeva la risoluzione del contratto stesso, oltre al pagamento della penale (anche al concedente una volta verificatasi la retrocessione dell’azienda).
La Corte ha stabilito che il concedente risponde solidalmente con l’affittuario della penale, senza che quest’ultimo sia liberato in quanto obbligato principale, ritenendo applicabile al caso di specie l’art.2560 del Cod.Civ. (operante quando il terzo contraente ha adempiuto alla sua prestazione e residua, pertanto solo un debito della parte inadempiente).
E ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta della risoluzione sia avvenuta dopo la retrocessione dell’azienda e quindi del trasferimento del contratto nuovamente al concedente ex art.2558 del Cod.Civ. e che si tratti di un contratto con prestazioni continuative o periodiche, in quanto ognuna di esse va considerata autonoma rispetto alle altre.
Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com
Contattaci subito per maggiori info!
Modulo di contatto
Dove siamo
Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma